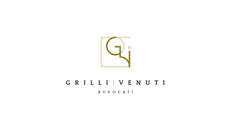Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto in via definitiva un dibattito giuridico che per decenni aveva diviso dottrina e giurisprudenza: è davvero possibile, nel nostro ordinamento, rinunciare alla proprietà di un immobile senza trasferirla a terzi?
La risposta della Suprema Corte è positiva, con conseguenze pratiche e sistematiche di notevole rilievo.
Per comprendere la portata della decisione è necessario partire dal contesto. Una parte della giurisprudenza aveva già ammesso la rinuncia abdicativa, richiamando l’articolo 832 c.c., che attribuisce al proprietario la facoltà di disporre del bene, e l’articolo 827 c.c., che disciplina l’acquisto da parte dello Stato dei beni cosiddetti “vacanti”. Secondo questa impostazione, l’ordinamento già contiene gli strumenti necessari a regolare la dismissione unilaterale della proprietà: il proprietario dichiara la rinuncia, la trascrive nei registri immobiliari e, automaticamente, il bene diventa di proprietà dello Stato. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia, aveva negato tale possibilità, ritenendo che la rinuncia non fosse configurabile in assenza di una norma specifica e paventando il rischio di una “proprietà acefala”, ossia un bene senza titolare nell’attesa dell’acquisizione da parte dello Stato. Questo contrasto è stato finalmente sciolto dalle Sezioni Unite. La recentissima sentenza Cass. SS.UU. 23093/2025 del 11 agosto 2025 ha chiarito che la rinuncia abdicativa è un atto giuridico unilaterale e non recettizio, che non richiede dunque l’accettazione di un altro soggetto. Essa rappresenta una modalità di esercizio del diritto di proprietà, in quanto espressione della facoltà di disporre riconosciuta dall’art. 832 c.c. L’effetto che ne deriva non è un trasferimento negoziale, ma un effetto legale: il bene, divenuto vacante, viene acquisito dallo Stato a titolo originario, per il semplice fatto della rinuncia e della sua trascrizione. Non occorre, quindi, alcuna manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione, perché l’acquisto è previsto direttamente dalla legge. La pronuncia assume rilievo anche dal punto di vista costituzionale. La Corte ha escluso che l’art. 42, comma 2, Cost., che subordina la proprietà alla sua funzione sociale, possa essere interpretato come un obbligo a mantenere indefinitamente la titolarità del bene. Le limitazioni alla proprietà devono essere poste dal legislatore, non possono derivare da un’interpretazione giurisprudenziale creativa. In altri termini, il proprietario resta libero di dismettere il proprio diritto anche solo per ragioni personali di convenienza economica, senza che ciò comporti la nullità dell’atto. L’interesse del rinunciante a liberarsi del bene è in sé meritevole di tutela, perché trova fondamento nell’assetto normativo generale.
Naturalmente, la rinuncia non è priva di limiti e di conseguenze. La Cassazione ha sottolineato che essa non produce effetti liberatori rispetto alle obbligazioni già maturate: restano dovute le imposte come IMU e TARI già scadute, gli oneri condominiali arretrati, gli obblighi di bonifica ambientale o di messa in sicurezza derivanti da situazioni pregresse, così come le responsabilità per danni verificatisi prima della rinuncia. L’atto, dunque, ha l’effetto di far venir meno la titolarità del diritto solo per il futuro, ma non cancella il passato. Da qui l’importanza, per chi valuta questa opzione, di un’analisi preventiva delle passività collegate al bene.
Un ulteriore profilo riguarda i rapporti con i creditori. La Corte ha precisato che la rinuncia alla proprietà è pur sempre un atto di disposizione patrimoniale: se compiuta al solo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, essa può essere impugnata attraverso l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c. In tali casi, la rinuncia viene considerata inefficace nei confronti dei creditori, che potranno agire come se il bene fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Dal punto di vista pratico, la decisione delle Sezioni Unite fornisce finalmente un quadro chiaro a chi si trovi a gestire immobili fatiscenti, terreni improduttivi o fabbricati gravati da costi di manutenzione e imposte superiori al loro valore di mercato. In tali situazioni, la rinuncia abdicativa rappresenta uno strumento estremo ma potenzialmente utile, che consente di liberarsi dal peso della proprietà e delle relative spese future. Resta però una scelta da ponderare attentamente, perché non risolve i debiti già maturati e può esporre a contenziosi con i creditori.
La portata della pronuncia va ben oltre il singolo caso. Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’istituto nell’alveo dei negozi di disposizione, superando l’incertezza interpretativa e riaffermando il principio secondo cui la libertà di disporre del proprio patrimonio è un corollario essenziale del diritto di proprietà. La decisione costituisce un punto di equilibrio tra libertà individuale e interessi generali, rimettendo al legislatore l’eventuale introduzione di ulteriori limiti e confermando che non spetta al giudice impedire al cittadino di rinunciare a un bene che non vuole più possedere.
Sentenza Cass. SS.UU. 23093/2025 del 11 agosto 2025
La sentenza Cass. SS.UU. 23093/2025 rappresenta una svolta importante: sancisce l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e delinea confini e responsabilità con chiarezza.
Non è uno strumento da usare a cuor leggero, ma può essere una via utile in casi estremi, quando il bene è un costo più che un valore.
Affinché la decisione sia efficace e sicura, è indispensabile il supporto di una consulenza legale esperta, che valuti rischi, modalità e conseguenze.